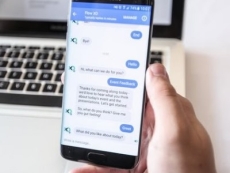Social network, quando un commento può costare il posto di lavoro
Si gioca sul crinale tra diritto di critica e offesa gratuita la partita tra lavoratori e aziende per i commenti sui social network. Se è lecito scrivere post commentando fatti realmente accaduti con un linguaggio moderato, la giurisprudenza non ammette invettive personali e attacchi non giustificati. Lo ha ribadito il Tribunale di Taranto con la sentenza del 26 luglio scorso, che si è pronunciata sul caso del lavoratore dell’ex Ilva licenziato per giusta causa per aver scritto sulla propria bacheca Facebook un commento su una fiction in cui accusava gli autori di non aver avuto il coraggio di fare il nome dell’azienda, concludendo con la parola «assassini».

Frase dura per il giudice e sicuramente offensiva ma troppo generica e non attualizzata - visto che la storia del film si riferiva a fatti accaduti negli anni duemila - per legittimare il licenziamento. Così il lavoratore è stato reintegrato.
Eppure di casi di lavoratori che finiscono in tribunale per “sfoghi” sui social network è piena la giurisprudenza.
L’ironia non salva il lavoratore dalla sanzione disciplinare, se il commento è pubblicato online e denigra l’azienda. Lo ha precisato il Tribunale di Ancona con la sentenza 175 pubblicata il 5 luglio, che interviene sulle recensioni pubblicate dai dipendenti su Google My Business. Nel caso specifico, il lavoratore aveva assegnato una sola stella su cinque all’azienda per la quale lavorava, lasciando come commento la frase «Lasciate ogni speranza…». Per il giudice, l’accostamento dell’azienda alla porta degli inferi risulta denigratoria, visto che anche le frasi ironiche o allusive possono essere offensive e ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Il licenziamento però è stato considerato illegittimo, perché sproporzionato rispetto alla condotta, mentre sarebbe risultata equa una sanzione disciplinare conservativa.
In un altro caso, i giudici sono intervenuti sulla portata offensiva degli hashtag aggiunti ai commenti. Per il Tribunale di Crotone «contribuiscono alla maggiore diffusione del messaggio rispetto ai quali dimostrano condivisione». In aggiunta a commenti pesanti e like, rendono quindi legittimo il licenziamento (sentenza 298 del 1 aprile 2021).
A Livorno è stata ritenuta proporzionata la sospensione dal servizio di trenta giorni irrogata al vigile urbano, aspirante comandante, che aveva pubblicato sulla propria bacheca Facebook numerose frasi denigratorie nei confronti del Comune di appartenenza. In questo caso, la sanzione è stata considerata proporzionale all’addebito, perché «la condotta del dipendente che pubblica frasi apertamente disonorevoli, con riferimenti tali da suscitare disprezzo o dileggio nei confronti del datore di lavoro non può essere tollerata» (Tribunale di Livorno, sentenza 191 pubblicata il 1° maggio 2021). Inoltre, l’articolo 10 del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti vieta espressamente di pubblicare online sotto qualsiasi forma «dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all’ente».
A ridimensionare le sanzioni irrogate dai datori di lavoro ai dipendenti è intervenuta la Corte Europea dei diritti dell’uomo con la pronuncia 35786 del 15 giugno scorso: non basta un “mi piace” su un post su Facebook per legittimare il licenziamento, perché sarebbe in contrasto con l’articolo 10 della Carta europea dei diritti dell’Ue che tutela la libertà di espressione.
È diverso il caso dei messaggi condivisi o scritti dal lavoratore. La Cassazione lo ha ribadito più volte: le offese pubblicate sui social network possono giustificare anche il licenziamento, perché sono idonee a ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Il diritto di critica, garantito dall’articolo 21 della Costituzione, non può essere invocato, perché riguarda commenti rivolti a eventi particolari che il lavoratore sottopone a giudizio negativo. Nei casi che giustificano le sanzioni disciplinari fino al licenziamento, si tratta di offese personali e generiche in grado di connotare in modo dispregiativo il datore di lavoro, senza alcuna critica specifica a condotte che si sarebbero verificate appunto sul luogo di lavoro. Ledono il rapporto fiduciario tutti i commenti che diffondono fatti non veri, insinuanti e che non trovano alcuna giustificazione obiettiva.

Di seguito i i princìpi fissati dai giudici:
Non rileva il post generico - Non può avere valenza disciplinare il post del lavoratore su Facebook non attualizzato, soprattutto se nel frattempo si sono avvicendate diverse proprietà aziendali. Frasi generiche come «accade», la «storia vera», non altrimenti contestualizzate, non possono violare gli obblighi di fedeltà a carico del lavoratore o il generale obbligo di correttezza e buona fede. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, sentenza del 26 luglio 2021
Stop a recensioni negative - I commenti e i punteggi negativi inseriti su piattaforme come Google My Business possono rilevare disciplinarmente per il lavoratore che li scrive, perché idonei a portare potenziali clienti, fornitori o dipendenti a non avviare affatto rapporti con la società recensita. Non rileva che non ci sia stata una flessione significativa nel punteggio assegnato all’azienda su Google. Tribunale di Ancona, sezione lavoro, sentenza 175 del 5 luglio 2021
No a commenti denigratori - La condotta del lavoratore che contribuisce a diffondere commenti denigratori rivolti all’azienda per la quale lavora tramite condivisioni, hashtag e “like” è connotata da particolare offensività ed è di gravità tale da pregiudicare la fiducia con il datore di lavoro. Tribunale di Crotone, Sezione lavoro, sentenza 298 del 1° aprile 2021.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 3 agosto 2021
Per leggere l'articolo integrale devi effettuare il login!