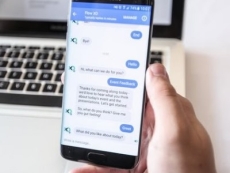L’insulto sui social network aperti a tutti può costare il licenziamento
L’uso disinvolto dei social media e dei sistemi di messaggistica digitale (WhatsApp, Telegram e simili) può portare in alcuni casi fino al licenziamento. I lavoratori troppo spesso dimenticano questo concetto. Tutto quello che viene scritto sui social, però, anche fuori dall’orario di lavoro, può essere usato in sede disciplinare, se ha contenuti offensivi verso il datore di lavoro e i colleghi, soprattutto quando questi contenuti sono indirizzati a una massa indistinta di persone.

Una frase razzista o sessista che genera un danno d’immagine all’azienda, un insulto pesante a un collega, la rivelazione di fatti che dovrebbero restare riservati: sono tutti esempi di come, con poche righe mal scritte sui social media(che si tratti di Twitter, LinkedIn, Facebook o affini), un dipendente può mettere a rischio il proprio posto di lavoro.
Rischio che non sempre si concretizza, perché la giurisprudenza sul tema ha un approccio ancora molto variabile: non mancano (e anzi sono la maggioranza) le decisioni che riconoscono la possibilità di licenziare per giusta causa chi pubblica frasi offensive verso l’azienda o i colleghi sui social, ma questa linea rigorosa è bilanciata da altre pronunce che fanno invece prevalere il diritto di critica, anche aspro, rispetto all’eventuale superamento dei limiti del decoro.
Un’altra distinzione emersa nella giurisprudenza più recente (si veda la sentenza del Tribunale di Firenze del 16 ottobre 2019 , commentata sul Sole 24 Ore del 19 novembre ) riguarda la platea che riceve eventuali messaggi offensivi: secondo questo orientamento, la rilevanza disciplinare dei messaggi cambia quando sono pubblicati su profili social aperti a tutti, o sono pubblicati su account o all’interno di chat telefoniche il cui accesso è filtrato e riservato.
Nel primo caso, l’eventuale contenuto offensivo del messaggio rileva sul piano disciplinare e, quindi, può essere contestato al lavoratore e utilizzato come motivo di licenziamento (qualora sussistano, ovviamente, gli elementi di gravità richiesti dalla legge). Nel secondo caso, la giurisprudenza equipara i messaggi inviati alla chat chiusa o pubblicati sul profilo ad accesso limitato alle forme di corrispondenza privata che, come tali, sono oggetto di tutela costituzionale e non possono essere usate per licenziare o sanzionare un dipendente.
Il tema delle comunicazioni sui social media interessa anche le relazioni industriali, con la diffusione delle “bacheche” digitali. Rispetto ai contenuti pubblicati su questi strumenti, i giudici tendono a distinguere tra l’esercizio del diritto di critica – assolutamente lecito e, anzi, oggetto di una tutela rinforzata per consentire l’espletamento del mandato sindacale – e la diffusione di informazioni e notizie false o di contenuto diffamatorio: in questa ipotesi, non basta la carica sindacale a salvare il lavoratore dal licenziamento (si veda la sentenza della Cassazione 10897/2018).
In queste situazioni la giurisprudenza tende a bilanciare il diritto alla privacy, sancito dagli articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori e dalle regole del Gdpr, con la necessità di consentire i controlli dei datori di lavoro sui profili social dei dipendenti, in presenza di determinate condizioni (una grossa apertura in questa direzione è venuta dalla sentenza della Cassazione 10955 del 27 maggio 2015 , che ha ritenuto legittimo il controllo svolto sui social media dal datore verso un dipendente tramite un falso profilo).
La questione diventa più complessa quando i messaggi pubblicati sui social media, pur essendo particolarmente sconvenienti (testi razzisti, incitamento alla violenza o alla droga, e così via), non c’entrano nulla con il lavoro. La possibilità per il datore di lavoro di contestare sul piano disciplinare questi comportamenti non è scontata, e mancano ancora orientamenti consolidati sul tema.
È probabile, tuttavia, che la giurisprudenza tenderà ad applicare lo stesso ragionamento già applicato alle condotte che non rilevano direttamente sul rapporto di lavoro ma che possono minare il rapporto fiduciario con il lavoratore. Usando questo metro, il datore potrà contestare e sanzionare la pubblicazione di un post “sconveniente” solo se potrà dimostrare che questa condotta ha leso il rapporto fiduciario e ha provocato un danno all’organizzazione aziendale.
Fonte: Il Sole 24 ore del 25 novembre 2019
Per leggere l'articolo integrale devi effettuare il login!